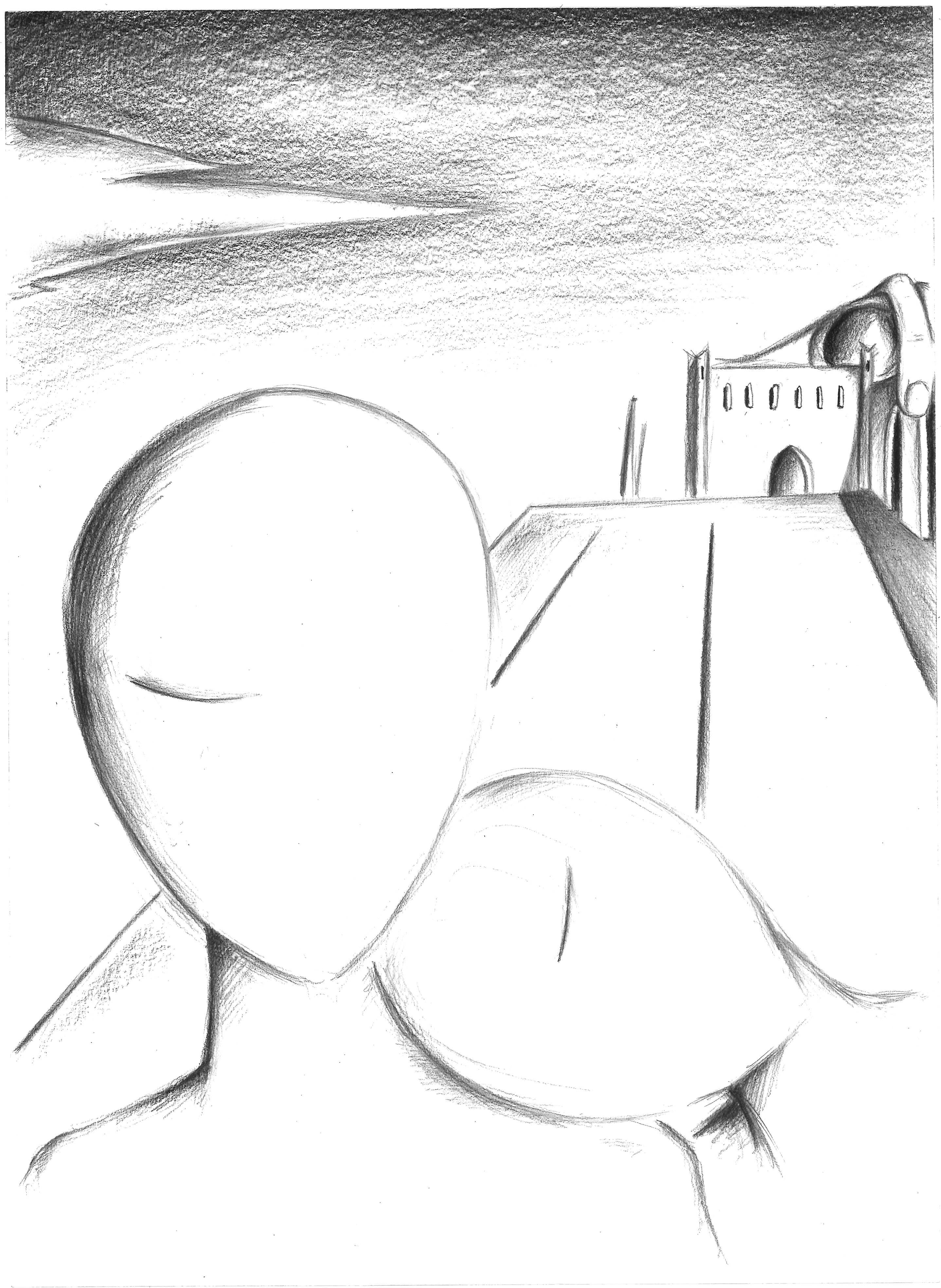Provare a riflettere senza dismettere il piacere della lettura e dello scrivere. Ci proviamo con questi due prossimi viaggi. Unendo le forze. Perché, quando c’è la musica di mezzo, Ork non può prescindere da Mork.
A presto!
Mork & Mindy

Provare a riflettere senza dismettere il piacere della lettura e dello scrivere. Ci proviamo con questi due prossimi viaggi. Unendo le forze. Perché, quando c’è la musica di mezzo, Ork non può prescindere da Mork.
A presto!
Mork & Mindy

Mentre mi inerpicavo nell’armonica bellezza che «La Grande Beune» (Adelphi Edizioni) restituisce al lettore nella traduzione di Giuseppe Girimonti Greco, che rende perfettamente la ricercatezza di un autore come Pierre Michon, senza rinunciare al dato sensibile che qui esplode prepotente, mi balenava per la testa la cadenza poetica dello svolgersi di un altro romanzo, cercato e poi trovato: «Acque strette», di Julien Gracq (L’orma editore), è il rimando etereo di quell’armonica bellezza che in Michon si fa “pioggia turbinosa”, “intonaco color sangue di bue”, “miele nero”, poesia che si sporca di vita, l’altra faccia dell’origine del mondo. Ork legge, abbina, completa, intesse i suoi puzzle e prova a dare un senso al percorso da tracciare da qui alla pausa estiva. E, intanto, cresce. Grazie ai libri. E medita di scrivere anche di Michon.
Mindy


Oggi ci è faticoso scrivere e ci è faticoso scrivere di donne in un momento complesso a livello internazionale e nazionale, in un momento difficile per le donne, per noi donne, ma proviamo a farlo, oggi più di ieri, e non solo perché vi sia un’urgenza sottesa alla contemporaneità, ma perché oggi, 8 marzo 2020, su Ork c’è la forza per farlo.
Lo facciamo ospitando un paio di libri che ci è parso potessero comunicare tra loro, anche nella diversità delle forme che ne agevola una salubre contaminazione, un reciproco supporto in un’ottica in cui il grembo delle donne è capace di accogliere, non necessariamente il simile, in una dimora di comprensione che supera la sfera intellettiva e si colloca oltre.
Lo dice bene Clarice Lispector in “Acqua viva” (traduzione di Roberto Francavilla), edito da Adelphi, un diario intimo, una lunga conversazione con se stessa nel tentativo di stare nel momento, di uscire dalle ansie di ricerca di un senso dell’esistere e dell’essere femminile che vada oltre la coscienza di un corpo che sa vivere nel presente e dell’attimo.
Atto di fiducia estrema, potremmo definirlo questo testo, rivolto alle percezioni di una parte di Sé attraverso cui si può dare una consistenza differente al proprio tempo, provando a fuggire via da ogni tentativo di approccio alla realtà che sia esclusivamente razionalistico. E questo è il lavoro più grande che compie la Lispector.
Non è l’esito del tentativo che a noi interessa o che ci prende e ci porta via fino alla conclusione del suo diario, ma è nel mentre che si avviluppa la nostra attenzione intorno alla sua irrequieta fatica di rappresentare, nel suo tempo, un’identità complessa e multiforme, di essere donna pensante che sente.
E questo viaggio, comune a molte di noi, diventa una sublime celebrazione di un equilibrio reso quasi perfetto dall’incastro lessicale e dalla sua aulica direzione d’orchestra, se non fosse per la frattura che ogni parola reca con sé, se non fosse per gli angoli spezzati che si leggono poco oltre il componimento estetico di sconcertante bellezza.
Il nucleo del diario è esattamente lì, però, nella “pesante ancestralità” da cui proviene, in una disperazione sottaciuta e urlata sotto la sfolgorante celebrazione della vita e dell’attimo attraverso il corpo, sotto “la vibrazione dell’allegro”, come se l’idillio del sentire non potesse che infrangersi contro la caducità della vita e l’insensato perdersi delle storie dietro a un orizzonte che non ci è dato conoscere.
Non si gretola, Clarice Lispector, se non nei margini. Deve “destituire” se stessa per raggiungere “la semenza viva” dell’istante, ma scrivendo si intrappola nelle lusinghe della logica, nelle classificazioni, negli schemi di genere. In fondo, è lei stessa ad ammettere che il meglio accade quando non sa nulla e fabbrica qualcosa di cui non coglie il senso.
Allora, che fare? Non scrivere? Se, oltre le parole, il pensiero coglie le tenebre dannose, la perdita di identità del mondo, l’inesistenza di ogni garanzia rassicurante, come reagire? Rinunciando alla scrittura? No, provando a vivere lo scarto offerto dalla parola, il vuoto oltre il pieno del discorso, il silenzio, la paura della domenica dopo l’affannarsi dei giorni fugaci di cui si compone il tempo della settimana, il dolore della solitudine nell’attimo successivo alla “gloria intima”, dove un tonfo sordo è solo il rintocco di una campana che segna l’inesistenza prossima.
Non resta che sottrarsi al dovere di andare fino alla fine, ottundersi per non soffrire, lasciare i dolori del mondo, uscire dal trotterellare nervoso, dal ritmo quotidiano che segna minaccioso lo scorrere del tempo, che suggella, senza possibilità di appello, l’ingresso nella vita e la sua fine, l’imminenza del passaggio verso l’altra parte dell’esistere: non resta che squarciare la delimitazione del reale, liberarsi, cercare una verità inventata, trasfigurare la realtà, crearne una “sognatrice e sonnambula”, fluire, lasciarsi accadere, entrare nel respiro del mondo, seguirne la voce, oltre l’assenza visibile di un ordine nel mondo.
E, nell’istante dell’urgenza del superamento del caos estetico, inseguire la bellezza nascosta, la leggerezza della grazia, la beatitudine scevra dal pensiero che necessita di forma, “la dissonanza armoniosa”, la vita intima “obliqua”, varcare i processi mentali che non contengono l’eternità, sapere senza sforzo, fare esperienza dell’intuizione, farla su di sé, scoprirsi inconcluse, disorganiche e, nonostante ciò, sentire che esiste un ordine soggiacente, l’umido essere implicito oltre l’esplicito, la sensualità della mancanza, il brutto, l’asimmetrico, che, contenendo per antitesi la simmetria e la bellezza, suscita l’incontro verso storie non addizionali, l’eros verso altri mondi dove il componimento sia fusione e generi la “splendidezza” di cui Clarice Lispector parla.

Ci piace pensare che la forma saggistica scelta da Sandra Petrignani per il suo “Lessico femminile”, edito da Laterza, il secondo libro che oggi ospitiamo, sia un contenimento materno alle ansie girovaganti per il diario della Lispector, laddove c’è spazio per la narrazione di una fragilità femminile oltre i ruoli imposti da una scrittura che ne sancisce un talento autoriale.
“Acqua viva” vibra senza mai cadere nell’induzione manipolatoria alla compartecipazione emotiva del lettore al diario della sua autrice, eppure la fragilità nell’angolo spezzato che sanguina nel silenzio oltre le parole è l’inno più sincero alla propria femminilità. Nel saggio la storia è differente, più ordinariamente raccontata, come forma impone, c’è spazio per un mondo di donne che, prima di scrivere, sono esseri femminili in cerca di un posto che sia loro, madri limitate e figlie ribelli, mogli tradite e amanti orgogliose. C’è un universo variegato dentro una narrazione scarna abbastanza da essere riempita delle mille variabili emotive di tutte noi, noi che conosciamo il segreto della vita, noi che accogliamo, generiamo, trasformiamo e sappiamo rinascere tutte le volte in cui la vita ci segnala che è giunto il tempo di chiudere un ciclo e iniziarne uno nuovo.
Ci siamo tutte e tutte ruotiamo intorno alla sorgente di Clarice Lispector: Anna Maria Ortese che mette al bando i contenuti narrativi per cercare il centro delle cose nella lontananza, nella malinconia, nella “memoria di patrie perdute” in cui si sostanzia la vera letteratura, una fuga necessaria dalla realtà che, vittima del tempo, decreta nascita, ma anche morte; Azar Nafisi che traduce il senso delle ricerca dentro la letteratura in un’epifania della verità che non si muove su un piano di realtà, può coincidere parzialmente con esso, ma sarà lo sguardo che ne smorza i confini a fare assurgere ai piani alti ciò che è visto; Edna O’Brien che coglie magnificamente l’origine dell’eccitazione sessuale femminile nel dolore e nella separazione dall’uomo, tutte le volte in cui l’atto consumato conduce a un isolamento da appagamento vincolato a fisiologiche dinamiche, laddove lei sarà nutrita, lui prosciugato. E potremmo proseguire.
Qualche giorno fa, ho erroneamente scritto nel giorno della morte di Sylvia Plath, riportando un passaggio di Clarice Lispector, che mi piaceva pensare a un incontro tra le due, alla forza dell’una che sorregge, in un sogno tutto al femminile, la fine “anticipata” dell’altra. Oggi che ne ho terminato la lettura, non sono più convinta di niente e mi abita il pensiero che la Plath sia stata coraggiosa almeno tanto quanto la Lispector: andare fino in fondo a se stesse è un atto di coerenza, come lo è suicidarsi di fronte all’inconciliabilità dell’amore per la vita con la sua fine, quando il guizzo che ci sostiene oltre il ragionevole accadere delle cose si spegne e ogni stimolo cede alla gravità.
Oggi Ork dedica le sue parole a tutte le donne, al coraggio con cui ostinatamente si cercano e non si tradiscono.
Mindy


Riconosciamo che oggi ci è difficile scrivere. Sono accadute un po’ di cose che richiedono dei tempi di assestamento, processi di metabolizzazione, attenzione alle ambiguità diffuse e recupero di un anelito di speranza che, nel silenzio del cortile di Ork, pur nel fresco preannuncio di un imminente autunno, fatica a soffiare.
Il vento soffia contrario a volte e la meta da raggiungere si fa più lontana, non per questo il desiderio di arrivarci cessa di essere motore indispensabile alla sopravvivenza, in quella umana dimensione che si nutre di roba aleatoria, di sogni, illusioni, utopie, quel calderone che fomenta rivoluzioni, non necessariamente globali. Lo racconta bene Simenon nel suo “Il Mediterraneo in barca”, edito da Adelphi (traduzione di Giuseppe Girimonti Greco e Maria Laura Vanorio), in quel passaggio in cui, nella narrazione di una traversata che è “una linea spezzata che va da Marsiglia a Messina fino al Pireo, da Smirne a Beirut fino a Porto Said, da Malta alla Sardegna fino a Tunisi, Tangeri, Barcellona”, non solo prende atto di non avere percorso, col suo equipaggio, il tratto sperato, ma di essere addirittura, per volere discorde dei venti, tornato indietro in un’attesa difficile da sostenere, ma necessaria: che la sorte, in forma d’aria propiziatoria, incominci a girare dalla sua e dalla loro parte.
Così il Mediterraneo, che, nelle prime pagine, Simenon fatica a definire, incomincia ad acquistare un’identità passando non solo dalla constatazione di quegli elementi naturali senza cui l’uomo può davvero poco, ma anche dall’esperienza che di essi fa ciascuno, e nella dimensione individuale e in quella condivisa in cui lo scambio diventa rito rievocativo di attività pregresse che si sostanziavano e si sostanziano nel commercio e nei derivati di utilità conseguenziali e, allo stesso tempo, incontro di culture, arricchimento, voci diverse che non si fondono, perché ciascuno porta la storia delle origini collettive da cui parte, ma si intonano nelle fragilità e nelle paure, nel non detto e nelle rassicurazioni, negli spazi, più o meno ambigui, in cui l’uomo è lo stesso, al fondo dell’abisso.
Reduci da un viaggio a Creta che ci ha letteralmente stravolto, imponendoci una serie di riflessioni che sono andate a scavare in quegli angoli in cui ciò che davvero conta si riduce all’estremo e si nutre di una fluidità che fatica a passare dalla forma verbale, ci è parso che la bellezza di questo insolito Simenon sia non nella descrizione dei luoghi, pure attenta e senza sbavature, laddove il viaggio è un toccare sponde, ripartire, sostare, immersi nella forza di ciò che ci sta attorno e che nel Mediterraneo è talmente amplificato da avere un’identità sua, quasi un terreno divinatorio in cui provare inconfutabilmente l’esistenza di un dio benevolo, che indugia sui piaceri, si fa corpo, supera le colpe e impone attese e rientri in un senso necessario e sfuggente, ma in sapienti nicchie di celebrazione di esperienze corporee incasellate nello scorrere descrittivo delle tappe, laddove una parola, un gesto, il riflesso sul corpo di un agire esterno raccontano l’intima essenza del sud e del Mediterraneo che raccoglie la storia di gente che naviga e pesca.
Lo stupore di Simenon è il frutto maturo di un viaggio che lo conduce in terre distanti dal nord, fuori dalle logiche del profitto e della programmazione, in cui esiste il presente, la magia della sospensione temporale di un’estate dilatata fino a comprendere l’eternità dell’esistenza, in cui il passato radica e il futuro si confonde all’orizzonte nell’imponenza dei piaceri e delle fatiche quotidiane che urgono.
Le pagine diventano un omaggio implicito alla cultura del sud, passando dalla primigenia forma di un ortodosso taccuino, sistematico e analitico in un equilibrio illuminato dalla ragione occidentale, per arrivare alla fine a un accenno di scioglimento, una storia diversa in cui fare confluire l’esposizione, la luce, ciò che è fuori, visto, toccato, vissuto col corpo, con la francese sensualità che tradisce, a tratti, fluidi vitali facendoli ordinariamente scorrere fuori dal pubblico sguardo.
Il viaggio non sempre passa da vie “liquide”, talvolta si svolge a terra, si nutre della forza e della tenacia di chi decide di intraprendere un cammino alla ricerca di un’Itaca ancora in divenire e si traduce nella narrazione di un percorso che conduce da un capo all’altro dell’isola e, forse, di se stessi, lontano dalle comodità, dentro gli impeti e la benevolenza del tempo, dentro l’anima dei villaggi, nelle taverne improvvisate in un’ospitalità evangelica che è fatta dell’oggi e della vicinanza, di un pasto caldo e di un bicchiere di vino, fuori dalle miserie che crescono in assenza di povertà.

Questo è “Rapporto a Kazantzakis” (Edizioni dei Cammini), il racconto di una traversata a piedi di un’isola speciale, possiamo garantirlo, quella di Creta, un pezzo di terra immersa in un mare blu che, a tratti, sospinto dalle forti correnti, pare non volere soluzioni di mezzo col resto del mondo e accogliere o mandare via, in un assoluto che è natura.
Creta è Creta, è anarchica e forte, Grecia dentro la Grecia o “solo” memoria e orgoglio minoici. Lo racconta bene Luca Gianotti senza pretese di scrittura “alta”, ma al solo scopo di condividere e diffondere un percorso che è “solo” un percorso nell’evidenza che la meta è un pretesto e il senso è racchiuso nelle giornate che al termine conducono, negli incontri, nella fortuita coincidenza di eventi, nella coscienza dei propri limiti e nell’idea che le sfide non sempre si esauriscono in voli mancati, spesso raccontano una forza che nasce dall’umiltà perché non esiste sfida che non parta dal basso.

Itaca è spesso molto prima della fine. Lo aveva detto bene Kavafis nella celebre poesia, ma, a ben guardare, la letteratura tutta è passata e ancora passa dal mito per raccontarci la storia dell’uomo, le sue aspirazioni, le sue miserie, i sogni traditi, il conflitto con l’irriducibilità di certi eventi, la fatica di accettare la morte, la morbosa declinazione delle relazioni familiari, il diritto e l’umanità oltre il rigoroso rispetto delle norme, le contraddizioni e l’ambiguità di chi nasce. È un omaggio al mito il libro che oggi chiude questo sipario di viaggio: “Sempre verso Itaca”, pubblicato da Stilo Editrice e animato da una profonda e sincera passione per il mondo classico e la Letteratura, un saggio che, scritto con cura da Bianca Sorrentino, vuole essere un detonatore di curiosità sopite in chi sa che non esiste rimedio migliore alla coscienza della fine di ogni cosa se non l’arte immaginifica che conforta con la forza delle parole e la bellezza che esse evocano in un senso che costruiamo lungo accidentate coordinate emotive e dell’anima.
Recita così una poesia di Golan Haji che la Sorrentino opportunamente cita e che ci racconta:
“Ho portato la mia notte illuminata dalla luna nella notte di tutte le anime,
e ho trottato come un topo all’interno di mura senza fine,
e non ho svegliato l’acqua in cui le stelle stavano dormendo.
E quando ritornai dov’ero nato,
io, che ero abituato a tornare indietro, fui costretto a rivivere tutto di nuovo,
cercai i miei compagni e con la polvere delle mie labbra ricoprii un’eternità senza parole”.
Ci piace pensare di esserci dentro e che, alla fine, quelle parole, dietro cui Ork va, si facciano aere, soffio, vento che ad Itaca conduce.
Mindy

Il nostro rientro e un classico che restituisce voce al nostro sentire, in attesa che Ork, complice Simenon, dica la sua sul senso di un viaggio in terra cretese.
«[…] Anche il Vangelo parla di poveri pescatori, no? Ebbene, qui siamo nella Bibbia, nel Vangelo. Centinaia di italiani, greci, turchi, siriani attraversano ogni giorno il Giordano in cerca della Terra promessa. Vanno dappertutto, in questo grande bacino, e non si sentono mai spaesati perché dappertutto è la stessa cosa. Un miscuglio di fasto e di miseria nera… A mezzogiorno il mare è piatto e liscio come la seta, due ore dopo la tempesta è al suo culmine… Le spighe crescono come per magia, e il caldo inaridisce il più piccolo filo d’erba […]» (Georges Simenon, “Il Mediterraneo in barca”, trad. di G. Girimonti Greco e M. L. Vanorio, Adelphi edizioni)




Mork & Mindy

E riemergiamo in questa strana estate.
È luglio inoltrato. Su Ork il caldo si fa asfissiante e dalla finestra della nostra stanza un cielo grigio preannuncia un pomeriggio di quelli da tempesta tropicale. Qui, a queste temperature si fa ancora fatica ad abituarsi e rimanere nell’alone immobile in cui è avvolta la città nei mesi estivi è una prova stoica che, se non fosse per necessità, eviteremmo volentieri.
Scrivere ultimamente non è stato semplice: qualche vecchio ricordo familiare, di quelli che ancora non hai sistemato del tutto, si è affacciato prepotentemente alla vita, si è imposto con forza sovrana, disperdendo fluide identità in cerca di sostegno.
Il ricordo, il dolore che si accompagna, mentre vicende che si schierano lungo la stessa balaustra della casa di infanzia accadono e ti travolgono nei sogni, pesanti come le storie da cui arrivi, diventano un freno allo scrivere.
Tutto troppo complicato, troppo doloroso, troppo difficile da sistemare e la valanga emotiva prende il sopravvento sulle possibili parole che curano.
Allora Ork si rintana, si chiude al mondo, si contorce su se stesso fino a quando non trova la chiave di accesso per dare alla vita il suo senso e ritrovare la forza per attraversarlo, quel senso, quel possibile senso, fino a metterlo in gioco, mutarlo, spostarlo, renderlo l’alba del giorno che verrà.
È estate e tutto dovrebbe vivere in una sua quiete. Dopo gli affanni dell’inverno, ogni cosa induce a lasciare andare, mollare tutto ciò che più non ci appartiene, a crescere nell’accezione di un riconoscimento di via alternativa ai costumi e ai sogni familiari.
E dal diritto si passa alla gioia delle Lettere, alla forza delle parole, a un percorso iniziato qualche anno fa e, poi, interrotto prima che la natura del sogno toccasse terra e si impastasse con essa in una combinazione felice in cui c’è vita oltre la morte di certi ricordi.
In autunno si profila qualcosa di nuovo, ma è presto per parlarne. I libri saranno protagonisti, fedeli compagni di un rinnovato viaggio verso nuovi confini e pezzi di identità da rafforzare, da coltivare, da nutrire, come si accudisce un bimbo, perché decretare la propria nascita è un po’ come mettere al mondo un figlio.
Oltre il giudizio altrui, oltre le aspettative di chi ti vuole bene, ma avrebbe voluto fossi diverso.
Il tempo si dilata e, laddove la città si svuota, le cicale irrompono come se stessero a un passo da te e non sul grande albero del cortile, i cani vicini guaiscono di gioia mentre giocano a contendersi il ramoscello lasciato incautamente in un angolo dal padrone ansioso di fuggire via dall’afa bolognese, su Ork la lettura domina, colma vuoti, genera coscienze, manifesta carenze, porta a galla storie di piccolezze in famiglie di grandi in cui essere se stessi non ha rilievo e l’onniscienza maschile, nella sua irraggiungibile posizione “olimpica”, schiaccia, toglie respiro, fino al momento in cui quel respiro lo cerchi e gli dai vita, strada, uscita, libertà di circolo partendo dai pertugi di un nuovo mondo, che ti fa paura, ma è un nuovo mondo ed è tempo di andare.
Robert e il suo viaggio verso la Cambogia, noi e il nostro viaggio oltre i confini del rassicurante conosciuto.
“Cacciatori nel buio” è un romanzo di Lawrence Osborne, ma è anche la nostra storia attuale.
E, allora, decidiamo di accoglierlo qui, dove le vite non sono, poi, un’appartata dimensione rispetto al narrare di chi è bravo a farlo per mestiere.
Se Robert lascia la tranquilla vita domestica di un piccolo paese inglese, dove insegna e dove nulla accade al di fuori di un recinto di condivisione familiare, e sente di dovere andare, gli orkers questo itinerario lo conoscono già.
Dal sud a Bologna per poi capire che Ork è oltre il sud, oltre Bologna, laddove il naufragio dell’uno ha trovato riparo nel porto dell’altro.
E, ancora, dal diritto alle parole, dalla musica all’arte: è tutto un fluire verso se stessi.
Il libro, edito da Adelphi, è stata una felice scoperta: il consiglio di un libraio bravo e appassionato, la nostra attenzione, il nostro rincorrere il senso delle cose in un filo che, se buddhista non è, lo è nella certezza che nulla accada per caso, gli incontri e gli incastri inverosimili quanto la vita nel viaggio di Robert e le strane storie di Ork, come recitava un film di nicchia di un’Italia scomparsa della mia giovinezza.
Dall’Inghilterra alla Cambogia il passo non è breve, ma neanche dal sud a Bologna e dalle origini verso un’ipotetica e salvifica ragione per cui siamo qui il passo può dirsi breve, ve lo assicuriamo.
I luoghi intorno, la natura, i visi, le sensazioni, lo spaesamento cercato e quasi felice nella coscienza di un’urgenza di perdersi per trovarsi, i temporali, il buio, il cibo speziato e i sapori forti, il caldo che brucia la pelle, diffonde acidi, le abitazioni fatiscenti, un senso di irrealtà in una dominanza, a noi occidentali sconosciuta, di una natura padrona delle vite e delle speranze di chi viaggia verso una fine del mondo e del proprio Io, i soldi che piovono dall’alto, dal gioco proibito, il segno di una permanenza che deve accadere, oltre i programmi: la prima parte del romanzo è questo e altro.
Poi, gli incontri: un uomo che vive sempre oltre il confine delle cose stabili, in una promiscuità decadente e affascinante, dove il Super Io è Dio e non c’è spazio per la quotidianità pacifica, solo eccessi e prova del potere, nell’inizio del viaggio verso il male di Robert in un gioco di rispecchiamenti che si fa scambio di vite, confusione, distorsione, perdita, paura, fino al finale ritrovamento di Sé reso possibile da un incontro di quelli che a Ork piacciono tanto.
Una donna cambogiana, una giovane che in una fedeltà assoluta al padre ne realizza il sogno di vederla medico esattamente come lui: Sophal, nome la cui radice racchiude un destino diverso, sceglie per sé, va incontro a una nuova storia, lontana dalle rassicurazioni paterne, impara l’inglese da Robert e coglie in lui quella ricerca inquieta di senso che è sua e che è la più grande rassicurazione che possa ricevere.
Non è più tempo di infantili solidità, di realizzare i sogni altrui, è tempo di andare: per Robert, Sophal e Mork e Mindy.
Il resto della storia è un intreccio di vite, di solitudini, di karma, di speranze disattese, di rabbia verso la vita che non raccoglie le nostre disperazioni, ma è anche la compassione, l’amore, la condivisione, quello sguardo univoco e speciale verso la vita che ci fa sentire meno soli, ci aiuta a credere che ci sia luce, oltre il buio, è apocalisse imminente in certe oscurità che si fanno talmente profonde da non lasciare speranza alcuna, è luce abbagliante dove è racchiuso il principio della fine, dove sono ormai cadute le ingenue certezze infantili, ma c’è ancora spazio per una nicchia in cui rispondere al finito con la passione di due corpi e con i desideri, quelli che sopravvivono alle mancanze, che si nutrono di coscienza di piccolezza e ci indicano, in fondo al sentiero, la possibile assenza di senso al di fuori della bellezza umile di esserci.
Mindy